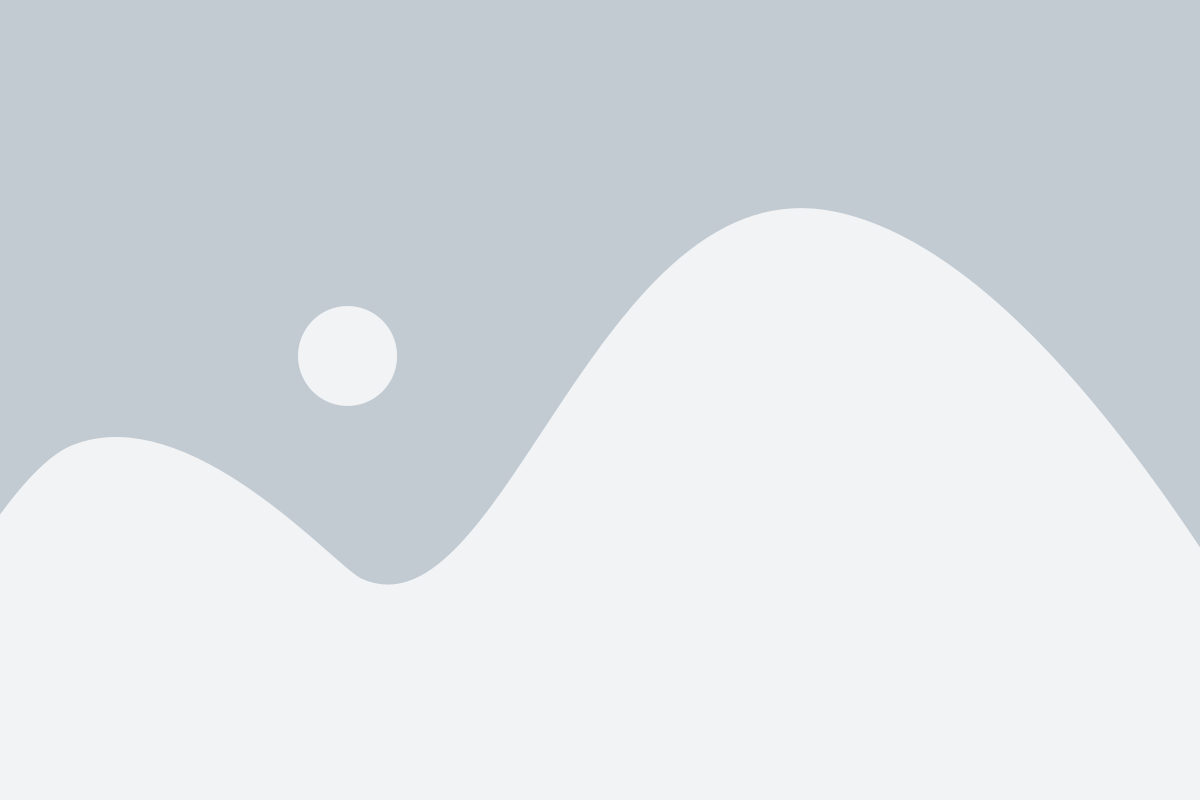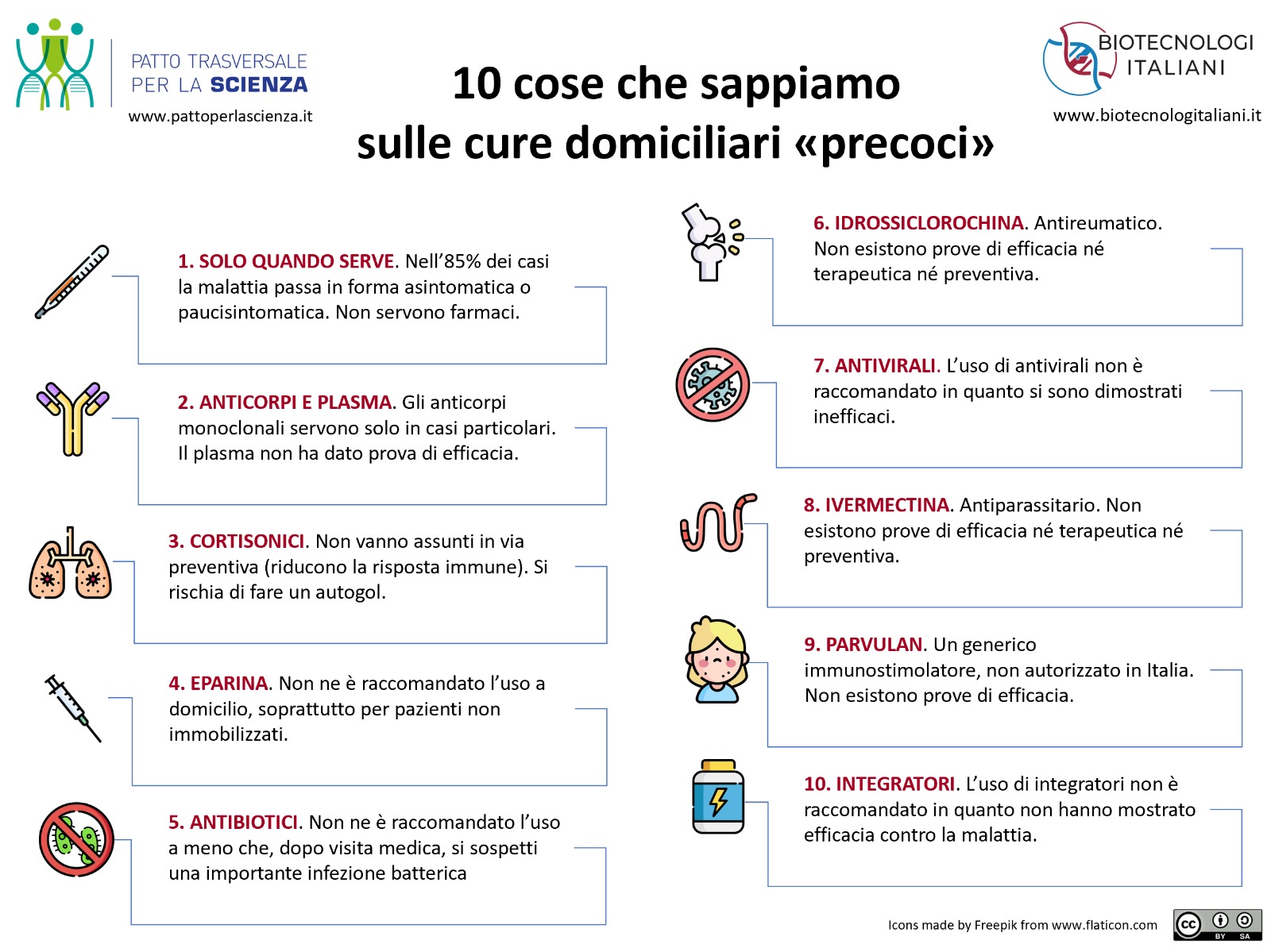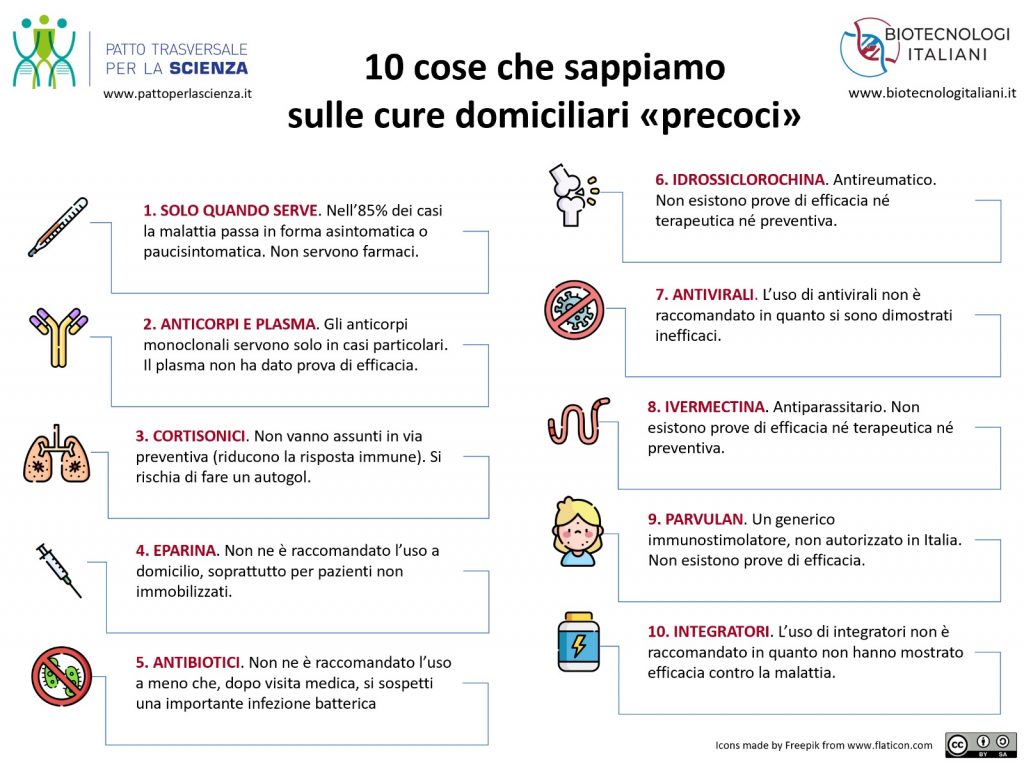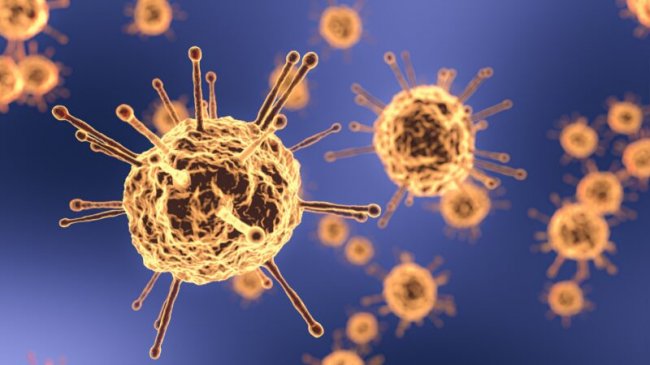“E’ opinione diffusa che il sistema del finanziamento della ricerca in Italia andrebbe profondamente modificato, avvicinandolo a quelli dei più importanti paesi occidentali. Il PTS in collaborazione con altri scienziati avanza alcune semplici proposte.”
di Piergiuseppe De Berardinis, Vincenzo Guardabasso, Micaela Morelli, Antonio Musarò, Guido Poli, Vincenzo Trischitta
Il finanziamento della ricerca in Italia è, ormai da molti anni, oggetto di dibattito e confronto fra gli scienziati e fra questi e il decisore politico che legifera in merito. Una parte consistente degli scienziati italiani lamenta sia l’esiguità dei fondi destinati alla ricerca sia la mancanza di coordinamento e trasparenza delle procedure di assegnazione dei finanziamenti. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si offre l’opportunità, forse storica, di modificare il sistema del finanziamento della ricerca in Italia, migliorandone gli aspetti critici e avvicinandoci alle abitudini e procedure dei più importanti paesi occidentali con consolidate tradizioni di ricerca. Con questa nota, il PTS offre il proprio contributo al dibattito sul finanziamento della ricerca in Italia, con particolare riferimento al settore biomedico.
Il documento si compone di
- una breve premessa generale sulla ricerca scientifica italiana;
- i risultati ottenuti da un’indagine qualitativa sul finanziamento della ricerca biomedica svolta con la collaborazione di alcuni ricercatori, per la gran parte italiani, ben inseriti in diversi paesi occidentali;
- alcune proposte e suggerimenti sul finanziamento della ricerca biomedica in Italia.
Premessa
Le condizioni generali della ricerca in Italia presentano varie criticità come dimostrato da diversi dati, alcuni dei quali sono qui riportati in estrema sintesi:
- I recenti dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) indicano un investimento in Italia dell’1,4% del PIL, ove la media Europea è del 2,1% mentre la Francia investe 2,2%, la Germania 3,2% ed Israele oltre il 4,5% del PIL. E meglio di noi fanno anche paesi come Ungheria, Repubblica Ceca ed Estonia, (articolo di Fulvio Esposito pubblicato dal PTS).
- I ricercatori in Italia sono 213.000 (dati OCSE 2019), mentre la Francia ha circa 430.000 ricercatori e la Germania 630.000, (articolo di Fulvio Esposito pubblicato dal PTS o vedi anche qui).
- In Italia, nel 2021, i nuovi dottori di ricerca (PhD) per 1000 abitanti nella fascia di età da 25 a 34 anni sono circa 65 contro i 100 della Francia, i 135 della Germania e i 140 del Regno Unito. Meglio di noi fanno anche Estonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna (dati dell’European Innovation Scoreboard 2021) (articolo di Fulvio Esposito pubblicato dal PTS).
- Stiamo perdendo una parte dei nostri migliori ricercatori, che sono numerosi tra i vincitori degli Starting Grants dell’European Research Council (ERC) (n=53, nel 2020, secondi solo ai tedeschi) ma che, purtroppo, in larga maggioranza (ben 33) hanno deciso di svolgere la loro ricerca in istituzioni straniere ove, presumibilmente, resteranno a lavorare alla fine del Grant ERC.
- Anche l’innovazione soffre di queste carenze, visto che lo European Innovation Scoreboard colloca l’Italia nel 2021 solo tra i paesi moderatamente innovatori. Meglio di noi fanno Francia, Germania, Olanda, Austria ed Estonia, per non parlare dei paesi scandinavi che sono leader dell’innovazione.
- E’ necessario sottolineare anche la scarsa presenza femminile in Italia in discipline scientifiche e che le donne in posizioni apicali sono un terzo degli uomini. Più in generale il numero di laureati in Italia è tra i più bassi d’Europa (dati EUROSTAT).
- Inoltre, il 50% dei ricercatori italiani ha una età tra 45 e 65 anni e solo poco più del 20% ha meno di 35 anni, età in cui la capacità ideativa e innovativa è ritenuta essere massima.
Finanziamento della ricerca biomedica in paesi occidentali
Senza alcuna pretesa di essere esaustiva e rappresentativa di tutte le realtà esistenti, la nostra indagine si è svolta ponendo una serie di domande preordinate ad alcuni ricercatori prevalentemente italiani ben inseriti in diversi paesi occidentali (Oreste Acuto in UK, Maria Grazia Biferi in Francia, Alessandro Doria in USA, Dolores Jaraquemada in Spagna, Silvia Maretto in Irlanda, Sandra Pellegrini in Francia, Michele Salanova in Germania, Maurilio Sampaolesi in Belgio e Francesco Saverio Tedesco in UK). I dati raccolti meritano un’analisi attenta e, verosimilmente, nuovi contatti con i nostri interlocutori, attività questa che è in cantiere per il prossimo futuro. Qui ci limitiamo a riportare le caratteristiche salienti che sembrano rappresentare un minimo comune denominatore del finanziamento della ricerca in ambito biomedico nei paesi sopra citati. Ci si riferisce solo ai progetti di ricerca “indipendenti” (cioè non pianificati dall’industria privata, quindi escludendo sia i trial clinici, sia la R&D intra-azienda, sia accordi diretti tra Industrie ed Enti di Ricerca).
- Il finanziamento al singolo ricercatore in maggioranza con fondi pubblici è pari a circa 100-200k Euro per anno per 3-5 anni (al netto degli stipendi). Quindi, generalizzando, finanziamenti annuali maggiori per un maggior numero di anni rispetto a quanto accade in Italia.
- Il processo di valutazione, sempre basato su revisione paritaria (“peer review”) è centralizzato in molti paesi, con commissioni di esperti sia nazionali sia esteri.
- In tutti i paesi sono prevalenti bandi per singoli ricercatori, sebbene esistano pure bandi per consorzi tra università, altri enti e/o spin-off. Per questa seconda tipologia, il processo è sia “top-down” sia “bottom-up”, a seconda dei paesi.
- I giovani ricercatori hanno opportunità speciali, ma il loro status dipende dagli anni di esperienza (max 7-10 anni dal conseguimento del PhD) e non dall’età anagrafica.
- Esiste spesso un portale Web che fornisce informazioni sui bandi, la loro valutazione e il loro svolgimento.
Finanziamento della ricerca oggi in Italia — Proposte per la ricerca biomedica
Relativamente alle politiche per i finanziamenti alla ricerca il PTS in precedenti documenti aveva indicato come principali criticità
- l’esiguità del budget complessivo
- la necessità di una migliore gestione per ottimizzare e razionalizzare l’uso delle risorse disponibili.
Riguardo al primo punto, ampia parte della comunità scientifica aveva sostenuto e fatto proprio l’appello lanciato dal fisico Ugo Amaldi, che chiedeva uno stanziamento di 15 miliardi fino al 2025. Successivamente il nostro governo tramite il PNRR europeo ha previsto l’erogazione di maggiori finanziamenti. Con qualche approssimazione, dovuta al fatto che non sono state ad oggi fornite notizie chiare e definitive, possiamo dire che il PNRR dovrebbe destinare circa 17 miliardi alla ricerca fino al 2026, 11 dei quali rivolti ad attività di ricerca industriale e sviluppo tecnologico. Il finanziamento direttamente dedicato alla ricerca cosiddetta “di base” dovrebbe quindi essere di circa 6 miliardi di euro. Molti meno di quanto ipotizzato dall’appello di Amaldi e molto probabilmente insufficienti perché la ricerca italiana colmi la distanza che la separa da quella di tutti i paesi occidentali economicamente avanzati.
Riguardo al secondo punto, l’assenza di un coordinamento rende possibile, se addirittura non facilita, procedure non sempre trasparenti e lineari per l’assegnazione dei fondi, che invece dovrebbe vedere una selezione esclusivamente basata sul merito.
La legge di bilancio del 2022 ha di fatto cancellato l’istituzione di una Agenzia Centrale della Ricerca sollecitata da anni da molti scienziati italiani, tra cui il Prof. Silvio Garattini e la Senatrice a vita, Prof.ssa Elena Cattaneo, e proposta dal precedente governo, con la motivazione del potenziale rischio di creare un ulteriore livello di controllo con relativo aumento di burocrazia. Tuttavia, come chiaramente si evince dall’analisi di ciò che accade nella maggioranza dei paesi occidentali che godono di consolidate tradizioni nel campo delle politiche per la ricerca (vedi sopra), permane la necessità di un migliore coordinamento delle risorse nazionali per la ricerca che renda le procedure di assegnazione dei fondi agili, trasparenti e competitive.
Al di là del modello organizzativo che il nostro Paese vuol darsi, resta irrinunciabile il fatto che il finanziamento della ricerca superi le logiche attuali. Riferendoci alla sola ricerca biomedica, che meglio conosciamo in quanto interesse diretto del PTS, seguono alcuni suggerimenti poco costosi e di semplice attuazione.
1. Bandire con tempistiche certe progetti coerenti con le necessità generali della ricerca in Italia e che promuovano innovazione. Le procedure di partecipazione ai bandi dovrebbero essere estremamente semplificate rispetto alle attuali che, a causa di regole burocratiche esagerate, frenano spesso la partecipazione di molti ricercatori, soprattutto se non supportati da importanti strutture organizzative/amministrative.
2. Garantire che la valutazione delle proposte sia basata su un attento sistema di “peer review”. Assicurare la presenza nelle commissioni di un elevato numero (almeno il 75%) di esperti appartenenti ad Istituzioni estere di comprovata esperienza nelle tematiche oggetto dei bandi. La partecipazione alle commissioni dovrà rispettare limiti temporali ed essere di massimo due mandati non replicabili per ogni singolo revisore.
3. Incoraggiare bandi per singoli ricercatori/laboratori di ricerca, limitando i “progetti a filiera” per evitare maxi aggregazioni in progetti che, essendo inevitabilmente in numero limitato, vanificano l’attività di una “peer review” rigorosa e competitiva.
4. Garantire che i giovani ricercatori cui, comprensibilmente, è riservata una parte dei finanziamenti, siano identificati come tali non per l’età anagrafica ma per gli anni trascorsi dal conseguimento del dottorato di ricerca o dall’ultimo titolo di studio conseguito.
5. Diversificare i bandi specifici per la ricerca da quelli che erogano fondi per strutture o infrastrutture dedicati alla ricerca.
6. Allestire un unico portaleliberamente consultabile che informi relativamente a:
i) bandi disponibili, ii) revisori; iii) risultati delle procedure di selezione dei progetti da finanziare e del monitoraggio dei progetti già finanziati (sia monitoraggio in itinere e alla conclusione, sia 3-5 anni dopo la fine del finanziamento, per valutarne i risultati in termini di pubblicazioni, brevetti, etc.).Tale portale servirebbe inoltre a monitorare il rischio di sovrapposizioni di assegnazioni a progetti simili, se non uguali, provenienti spesso dallo stesso laboratorio, magari semplicemente cambiando l’indicazione del “principal investigator”. La valutazione ed il monitoraggio dovrebbero interessare anche i bandi per strutture o infrastrutture, verificandone sia il coinvolgimento/uso in ambito nazionale e internazionale sia la sostenibilità economica (derivabile dal rapporto tra costi e ricavi per l’espletamento di attività “in service”).